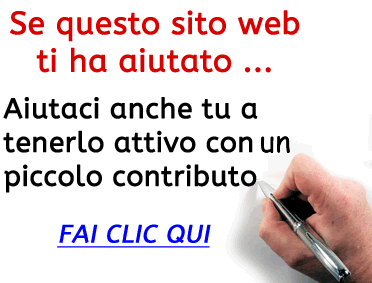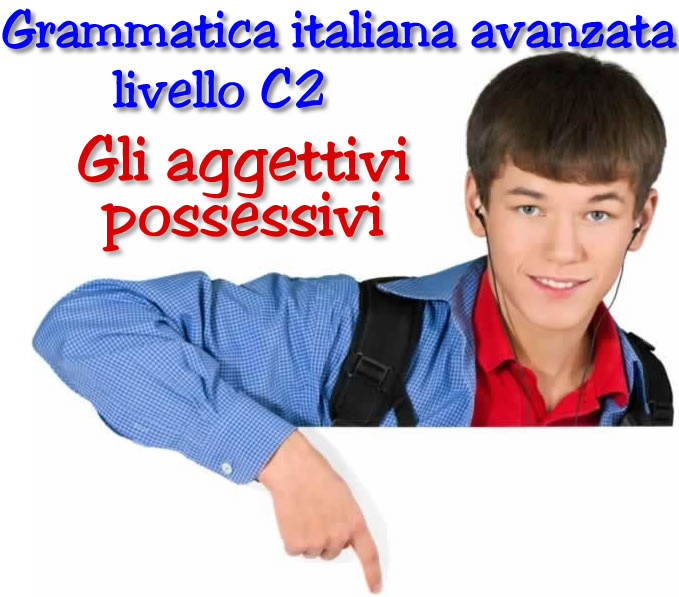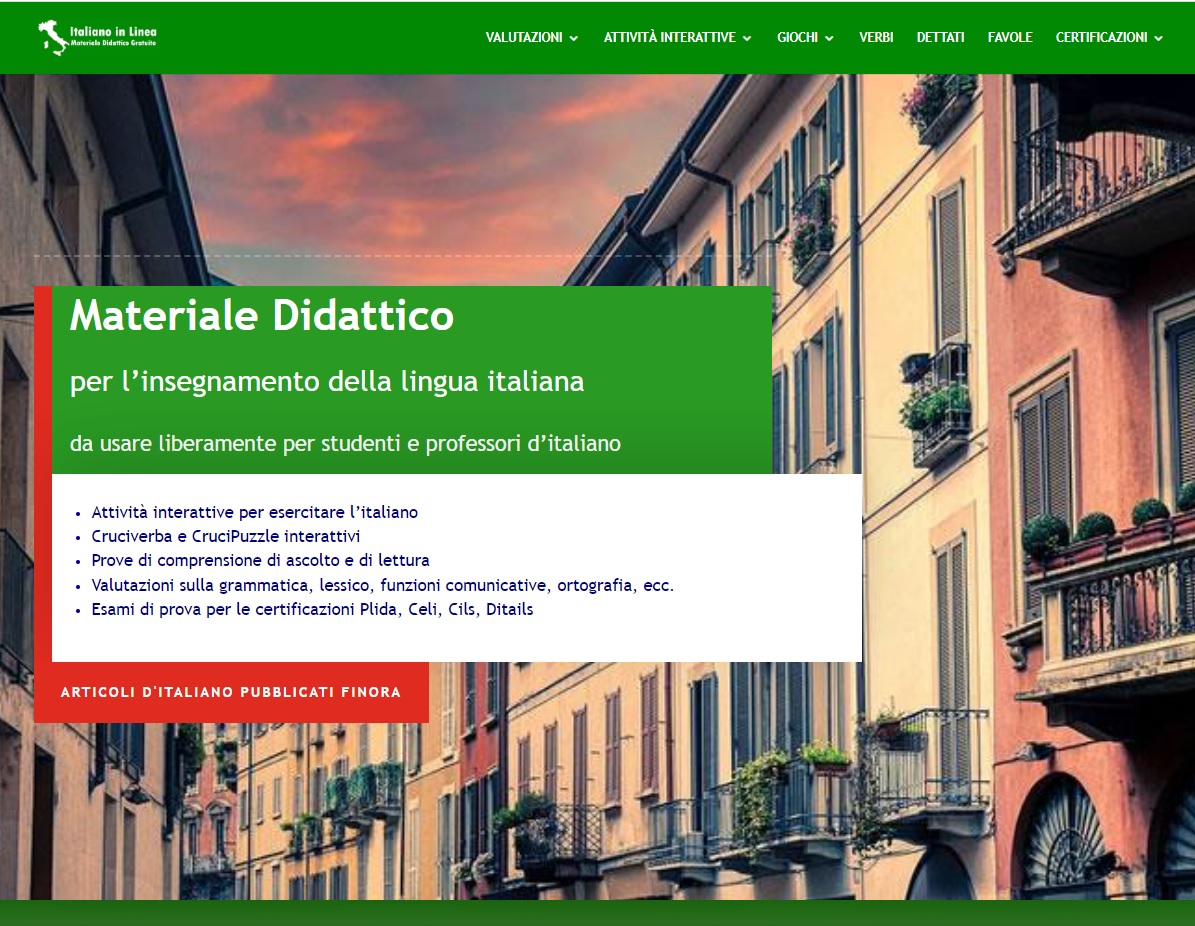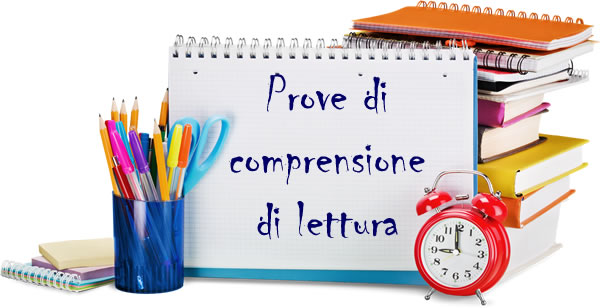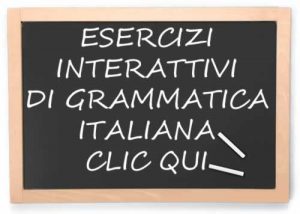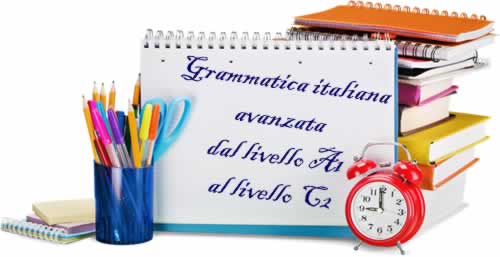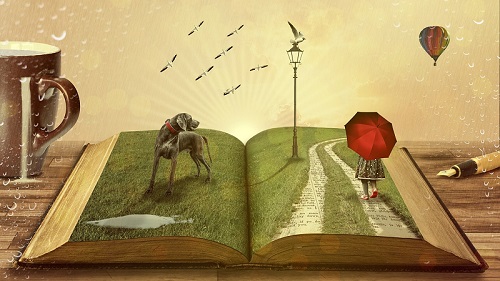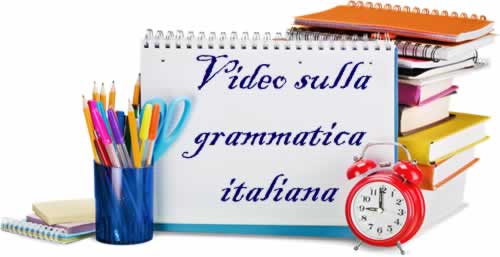Gradi dell’aggettivo qualificativo
I gradi dell’aggettivo qualificativo, stabiliscono il grado d’intensità con cui tale qualità è posseduta, potendo stabilire un confronto rispetto ad un’altra persona o cosa, rispetto a tutti gli altri individui della medesima specie o indicare tutta l’intensità massima possibile senza bisogno di stabilire alcun confronto.
I gradi dell’aggettivo qualificativo possono essere tre: «positivo«, «comparativo» e «superlativo«.
- Il grado positivo: si limita a esprimere solamente la qualità dei nomi in modo generico, senza indicare la misura e neanche se è posseduta in modo maggiore o minore rispetto ad altre cose o persone:
Carlo è simpatico
In questo esempio, l’aggettivo simpatico riferito a Carlo, non specifica quanto è simpatico Carlo e neanche se è più o meno simpatico rispetto ad altre persone.
- Il grado comparativo: stabilisce un paragone fra due nomi con rispetto a una stessa qualità o fra due qualità con rispetto a un nome o fra due verbi. I due elementi messi a confronto (nomi o qualità) si chiamano primo e secondo termine di paragone.
Il comparativo può essere di tre tipi: comparativo di maggioranza, minoranza o uguaglianza.
- Comparativo di maggioranza: quando la qualità attribuita al primo termine di paragone è in misura maggiore alla qualità attribuita al secondo termine di paragone.
Questo comparativo si forma ponendo l’avverbio più davanti all’aggettivo e introducendo il secondo termine di paragone con di o con che
Roberto è più alto di Francesco
Lavorare è più faticoso che studiare
Monica è più intelligente che bella
-
- Comparativo di uguaglianza: quando la qualità attribuita al primo termine di paragone è presente in misura uguale alla qualità attribuita al secondo termine di paragone.
Questo comparativo si forma mediante le correlazioni tanto … quanto, così … come, oppure, più semplicemente, con quanto e come posti davanti al secondo termine di paragone
Roberto è tanto alto quanto Francesco
Roberto è così alto come Francesco
Roberto è alto quanto Francesco
Roberto è alto come Francesco
Il confronto potrebbe avvenire mettendo in relazione due comparativi (di maggioranza o di minoranza) con un terzo termine di paragone:
Roberto è tanto più intelligente di Francesco quanto Luigi.
-
- Comparativo di minoranza: quando la qualità attribuita al primo termine di paragone è in misura minore alla qualità attribuita al secondo termine di paragone.
Questo comparativo si forma ponendo l’avverbio meno davanti all’aggettivo e introducendo il secondo termine di paragone con di o con che
Roberto è meno alto di Francesco
Studiare è meno faticoso che lavorare
Monica è meno bella che intelligente
- Il grado superlativo di un aggettivo qualificativo, indica che una determinata qualità è posseduta da qualcuno o da qualcosa al massimo livello.
Esistono due tipi di grado superlativo: assoluto e relativo.
- Superlativo assoluto: non introduce confronti con altri termini, attribuisce al nome una qualità in grado massimo e in maniera assoluta e si forma:
aggiungendo al tema dell’aggettivo di grado positivo, privato della desinenza morfologica, il suffisso –issimo potendo modificare la desinenza a seconda del genere e del numero del sostantivo a cui si riferisce:
Il libro è bellissimo
la rivista è bellissima
i libri sono bellissimi
le riviste sono bellissime
Gli aggettivi che terminano in io come solitario o pio conservano la (i) se è tonica (accentata), invece si unisce a quella della desinenza quando è atona (non accentata):
solitario – solitarissimo (i tonica)
pio – piissimo (i atona)
Gli aggettivi in –co e –go davanti al suffisso –issimo conservano il suono palatale o gutturale che hanno nel plurale maschile del grado positivo:
simpatico – simpaticissimo
lungo – lunghissimo
usando avverbi intensificativi come sul serio, davvero, proprio, veramente:
sono davvero contento di rivederti
tuo figlio è proprio intelligente
mettendo prima dell’aggettivo di grado positivo prefissi come arci-, ultra-, stra-, extra-, sovra-, super-, iper-:
sono arcicontento che tu abbia vinto
quella persona è straricca
mettendo prima dell’aggettivo di grado positivo un avverbio di quantità che ne rafforza il significato, come molto, assai, oltremodo, sommamente, immensamente, infinitamente, decisamente, incredibilmente, estremamente ecc.:
La pizza è molto buona
L’esercizio è estremamente difficile
mettendo davanti all’aggettivo l’avverbio tutto:
Il ragazzo era tutto bagnato
duplicando l’aggettivo di grado positivo:
si sono dati un abbraccio forte forte
rafforzando l’aggettivo di grado positivo con un altro aggettivo di significato analogo:
stasera non esco perché sono stanco morto
- Superlativo relativo: attribuisce al nome una qualità in grado massimo (superlativo relativo di maggioranza) o in grado minimo (superlativo relativo di minoranza), ma no in modo assoluto, bensì in relazione a un gruppo di persone, animali o cose e si forma mettendo il più o il meno davanti all’aggettivo:
Roberto è il più intelligente
Wolf è il cane meno pericoloso
Il gruppo di persone, animali o cose con il quale avviene il confronto, può essere introdotto dalle preposizioni di, tra o fra:
Roberto è il più intelligente della classe
Wolf è il cane meno pericoloso fra questi
Il superlativo relativo si differenza dal comparativo di maggiorana o di minoranza per avere un articolo determinativo davanti all’aggettivo o al nome:
è stato il film più bello della stagione
Roberto è il più simpatico della famiglia
Alcuni aggettivi possono formare il superlativo relativo e il superlativo assoluto usando una forma del tutto diversa rispetto a quella corrispondente all’aggettivo di grado positivo e vengono chiamati comparativi e superlativi organici:
buono (grado positivo)
migliore (superlativo relativo)
ottimo (superlativo assoluto)
cattivo (grado positivo)
peggiore (superlativo relativo)
pessimo (superlativo assoluto)
grande (grado positivo)
maggiore (superlativo relativo)
massimo (superlativo assoluto)
piccolo (grado positivo)
minore (superlativo relativo)
minimo (superlativo assoluto)
Ci sono inoltre aggettivi che indicano una qualità che non può essere posseduta in grado maggiore o minore, che sono privi di comparativo e superlativo:
quadrato
chimico
mensile
francese
Anche gli aggettivi che già da soli danno l’idea del superlativo sono privi di comparativo e superlativo:
immenso
eterno
infinito
enorme